di Guglielmo Forges Davanzati
La ripresa della crescita economica in Italia viene fatta dipendere, nella visione dominante[1], dal combinato della liberalizzazione del mercato dei beni e dei servizi e da misure di deregolamentazione del mercato del lavoro, secondo gli effetti descritti nella seguente tabella.
(Fonte: Tronti 2009) [2]
Si tratta di uno schema che presenta non pochi punti di criticità, sia sul piano teorico, sia sul piano fattuale. Ciò che qui interessa rilevare è se la moderazione salariale può essere una strategia efficace ai fini della crescita delle esportazioni e se lo sia ai fini dell’aumento della domanda interna (per effetto del presunto aumento dei salari reali conseguente alla riduzione del tasso di inflazione). Tecnicamente, la risposta alla prima domanda rinvia alla stima dell’elasticità delle nostre esportazioni al prezzo, ovvero della possibilità, per i consumatori esteri, di sostituire facilmente i prodotti italiani con prodotti di altri paesi. A riguardo non vi è uno studio che possa considerarsi conclusivo, soprattutto in considerazione del fatto che l’elasticità delle esportazioni al prezzo varia significativamente fra settori produttivi.
Una ricerca relativamente recente di Banca d’Italia[3] attesta che i consumi dei beni esportati da imprese italiane non risentono in modo significativo del loro prezzo e che l’elasticità delle nostre esportazioni è inferiore a quella dei principali paesi dell’eurozona. Questo risultato non è sorprendente se si considera la specializzazione produttiva dell’economia italiana e la composizione del suo tessuto produttivo.
ISTAT certifica che la struttura produttiva italiana è prevalentemente composta da imprese di piccole dimensioni, con bassa propensione all’innovazione e poco presenti sui mercati internazionali. Le imprese più esposte alla concorrenza internazionale sono localizzate al Nord. La nostra specializzazione produttiva è in settori “maturi”: agroalimentare e made in Italy, con un comparto dei macchinari sempre più esiguo. La rilevazione di Banca d’Italia appare così pienamente coerente con questo scenario: i fattori che contano ai fini della crescita delle esportazioni non attengono alla competitività di prezzo.
Le imprese italiane esportano puntando sulla qualità dei prodotti e, nel caso del beni di lusso, semmai su prezzi elevati, dal momento che, per l’operare del c.d. effetto Veblen (per il quale la domanda aumenta all’aumentare del prezzo), un bene di lusso viene acquistato in quantità maggiori se il suo prezzo è elevato. In più, e soprattutto per quanto attiene ai beni di lusso, le nostre esportazioni dipendono essenzialmente dalla dinamica della distribuzione del reddito su scala globale: tanto più essa è diseguale, tanto maggiore è la domanda di beni di lusso rivolta alle imprese italiane.
D’altra parte, in considerazione del fatto che l’economia italiana è dualistica, misure di incentivazione delle esportazioni (p.e. le svalutazioni competitive pre-euro) non hanno altro esito se non accentuare le divergenze regionali. E vi è da aggiungere che il tasso di cambio, in linea generale e ancor più nel caso italiano, risente profondamente dei movimenti speculativi di capitale[4], così che la sua svalutazione potrebbe non avere alcun effetto sulla bilancia dei pagamenti e potrebbe semmai avere effetti di segno negativo sulla propensione – già bassa – delle nostre imprese a innovare[5].
Il Rapporto ISTAT 2015 sul sistema produttivo italiano certifica che, negli ultimi anni, i principali aumenti di esportazioni si sono avuti verso la Germania e che le imprese esportatrici sono quasi tutte localizzate al Nord. Si tratta di imprese alle quali ancora interessa la ricerca di base e applicata e ciò potrebbe dar conto del progetto di accentramento delle risorse per la ricerca in pochi poli localizzati nel Nord del paese e del conseguente sottofinanziamento delle università del Mezzogiorno[6]. Peraltro, già a regime, la spesa per ricerca e sviluppo è notevolmente superiore al Nord rispetto al Sud.
In più, per le imprese che operano sul mercato interno la moderazione salariale è semmai controproducente. Va premesso, a riguardo, che la riduzione dei salari monetari tende a non associarsi a un aumento dei salari reali netti (e dunque del reddito disponibile) soprattutto a ragione del fatto che l’imposizione fiscale grava prevalentemente sul lavoro dipendente[7]. Vi è di più. Se anche la riduzione dei salari monetari dovesse implicare un aumento dei salari reali, l’elevata incertezza (indotta soprattutto dalle condizioni di lavoro precario) induce risparmi precauzionali limitando il potere d’acquisto. La conseguente riduzione dei consumi genera i seguenti effetti:
a) Dal lato della domanda, la caduta dei consumi, a parità di investimenti pubblici e privati, riduce la domanda aggregata e il tasso di crescita, con un effetto amplificato dal fatto che, di norma, le famiglie con più basso reddito esprimono una propensione al consumo maggiore di quelle con redditi più elevati. A ciò si aggiunge che la compressione dei consumi tende a disincentivare gli investimenti privati, con effetti, anche in questo caso, di segno negativo sulla domanda aggregata.
b) Dal lato dell’offerta, la riduzione dei salari monetari pone le imprese nella condizione di competere comprimendo i costi e, per questa via, disincentiva l’introduzione di innovazioni, con effetti di segno negativo sul tasso di crescita della produttività. I seguenti ulteriori meccanismi amplificano questa dinamica.
In primo luogo, la riduzione della domanda interna riduce i mercati di sbocco a danno innanzitutto delle imprese che operano sul mercato interno, con conseguente compressione degli investimenti e del tasso di crescita della produttività del lavoro[8].
In secondo luogo, e a questo associato, la riduzione dei profitti monetari riduce le fonti di autofinanziamento delle imprese e ne accresce il grado di dipendenza dal settore bancario. La compressione dei margini di profitto, a seguire, in quanto accresce il rischio di insolvenza, induce le banche a ridurre l’offerta di credito (o ad aumentare i tassi di interesse sui prestiti) generando, anche per questa via, riduzione degli investimenti e della produttività. Non è un caso che le passività finanziarie sono di gran lunga maggiori nel Mezzogiorno. E non è un caso che i divari regionali continuano inesorabilmente ad aumentare.
—
Note
[1] Si rinvia, in particolare, a O. Blanchard e F. Giavazzi (2003), “Macroeconomic effects of regulation and deregulation in goods and labour markets”, Quarterly Journal of Economics, 118, 3.
[2] L. Tronti (2009), La crisi di produttività dell’economia italiana: scambio politico ed estensione del mercato, “Economia e Lavoro”, XLIII, pp. 139-157.
[3] Si veda https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2015-0280/QEF_280.pdf?language_id=1.
[4] Determinandosi secondo modalità proprie di un “concorso di bellezza”, secondo la definizione datane da Joseph Halevi: http://www.palermo-grad.com/non-esistono-mezzogiornificazioni.html.
[5] A. Graziani (2000), Lo sviluppo dell’economia italiana dalla ricostruzione alla moneta unica, Bollati Boringhieri, Torino.
[6] G. Forges Davanzati, “La distruzione dell’Università e le ragioni di chi si oppone”, MicroMega-online, 26 gennaio 2016.
[7] OCSE certifica che la tassazione sul lavoro dipendente, in Italia, è fra le più alte in Europa e nel confronto con i principali paesi industrializzati: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AWCOMP.
[8] A. K. Dutt (2012), “Distributional dynamics in Post-Keynesian growth models”, Journal of Post Keynesian Economics”, 34(3), Spring: 431-51.
Pubblicato su MicroMega-online l’11 maggio 2016.

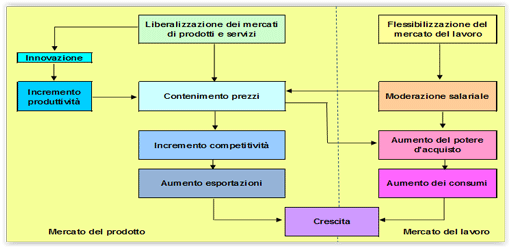


![Una donna controlla le informazioni sul cibo specificate sulla confezione [foto: archivio]](https://www.eunews.it/wp-content/uploads/2014/12/Etichette-alimentari.jpg)


![Ragazza in biblioteca. Nell'Ue chi studia non lavora e neppure cerca. In Italia funziona ancor più così [foto: Tulane University, Wikimedia Commons]](https://www.eunews.it/wp-content/uploads/2024/11/Girl_in_the_Library_3638661587-350x250.jpg)



