di Pierluigi Fagan
Rampini è un reporter sul fronte del presente con un occhio alle avanguardie che si proiettano verso il futuro. La sua cronaca del presente è passata dalla new economy, alla Cina, a Cindia (Cina + India), all’India, alla banco-finanza con un occhio sempre attento alla rete, per poi tornare ogni tanto all’America, all’Occidente, all’Europa e sempre meno, all’Italia. Fa il giornalista e non gli si può chiedere di far di più. Oggi si occupa di caos, la cifra della contemporaneità che tende al futuro.
Il suo libro è quindi un report in nove capitoli più intro e conclusioni, sullo stato caotico della contemporaneità. Rampini non spiega e non giudica, racconta a modo suo, scegliendo esempi, casi, fenomeni che non angoscino troppo ma diano il senso di quanto potente sia un cambiamento che si annuncia permanente, ad un pubblico che si trova al confine tra la cultura e l’informazione.
Di tutti i casi che racconta due mi sembrano emblematici per inquadrare il suo punto di vista. Uno è sparpagliato nelle narrazioni e ci dice che il genovese, migrante a Bruxelles all’età di due anni e poi globetrotter prima per il Sole, poi per Repubblica, ha ottenuto la doppia cittadinanza ed è quindi italiano ma anche statunitense. Il suo punto di vista occidentale è quindi per nulla italiano, molto poco europeo ed ormai abbastanza interno alla mentalità “colta” americana ovviamente di sinistra e progressista tipo Rifkin, Stiglitz, Sachs, Mason, Reich. L’altro è il racconto della scelta di Andrew Sullivan, uno dei primi blogger di successo e pioniere del giornalismo online indipendente che ha improvvisamente chiuso la sua attività sulla rete dopo quindici anni (Daily Dish). Perché? «Voglio tornare al mondo reale. Leggere lentamente, attentamente. Scrivere un libro… lunghi saggi che rispondano in modo approfondito e più sottile alle questioni che si sono presentate in questi anni».
Sullivan ha fatto il pieno di orizzontalità, ora sente il bisogno di verticalità. Traspare qui, il principio di indeterminazione della conoscenza che ad un polo ha questi orizzontalisti dell’informazione, del commento, della polemica che dicono su tutto ma significano poco e dall’altro i verticalismi del sapere, dell’approfondimento specialistico, del linguaggio esoterico di questa o quella remota contrada disciplinare che significano molto ma di porzioni che valgono molto poco per comprendere i fenomeni generali. Conoscere, sapere, comprendere, capire, ci si dibatte in questo quadrilatero gnoseologico i cui oggetti, però, sono in genere molto parziali ritagli del Tutto.
Forse Rampini, prima o poi, sceglierà anche lui di smettere di fare l’ape ronzante su i mille fiori che sbocciano al mattino della nuova storia e, preso dalla sindrome della saggezza che coglie, fatale, ad una certa età, si metterà a riflettere al fondo delle cose. Glielo auguro. Nelle conclusioni (provvisorie e leggere), Rampini cita il libro di Julien Benda Il tradimento dei chierici (Einaudi, 2012), Scritto nel ’27, il saggio è una sfuriata indignata contro i traditori dell’intelletto e della ragione. Quegli intellettuali che defezionano dal ruolo terzo di custodi se non dell’impossibile avalutatività weberiana, almeno dell’onestà intellettuale, della visione storica, della difficile comprensione del tutto ma anche del suo contrario, per diventare apologeti di una fazione in lotta, quando non servi di uno dei mille poteri in lotta per l’egemonia. Ed a questo principio di terzietà sembra volersi ispirare anche il nostro che nei dieci capitoli del suo racconto, ci porta da spunti veloci di geopolitica all’economia sempre più banco-finanziaria, dall’America alla Cina, all’India sempre bilanciando luci ed ombre, dalle questioni ambientali, alle tecnologie, fino ai poteri non neutrali della scienza, accennando al problema dei migranti e tornando spesso a parlare della rivoluzione digitale.
Il succo conclusivo, Rampini lo trova in una citazione a cui premette: «Allora una strada per uscirne deve anche partire da qui: dalla ricerca paziente delle rarissime voci scomode, che accettano la contraddizione, abbracciano la complessità, cercano di indagare onestamente i propri errori, e riconoscono perfino qualche sprazzo di verità in chi sembra l’opposto di sé». La citazione è dal libro di un medico americano, Kabat-Zinn ed all’interno le due paroline magiche: “reciprocità ed interconnessione”. L’invito al superamento del manicheismo è forse dovuto allo stato attuale della separazione frontale delle mentalità che c’è negli Stati Uniti ma è anche vero che gli enti complessi (ad esempio il “mondo”) non rispondono alla logica dicotomica.
Insomma, Rampini non esprime giudizi, illustra solo lo stato incipientemente caotico del mondo, scegliendo alcuni linee di faglia per darci un racconto di quel presente, il cui futuro diventa viepiù incerto.
Il movimento principale è ovviamente la pressione esercitata dalle società-economie-demografie affluenti (BRICS ma non solo) sul sistema occidentale che Rampini interpreta, soprattutto, come americano. Di questo Resto del Mondo, si concentra su Cina ed India. Inquinamento, corruzione, invecchiamento demografico, rischi di tensioni sociali e rivendicazioni salariali, bolle speculative, squilibri città-campagna e migrazioni interne, la Cina di Rampini è una porcellana piena di incrinature che potrebbero portare a vere e proprie, imminenti, rotture. Il mastice che regge ancora il sistema è dato dal nazionalismo e dal leaderismo di Xi Jinping, uomo forte che incarna un autoritarismo confuciano, versione più hard di quello singaporiano, l’alto tasso di risparmio, i piani della nuova banca di investimenti ed il rinnovato progetto della Via della Seta, le nuove modernissime infrastrutture e la dedizione, anch’essa confuciana, allo studio. Qualche anno fa, il nostro, era più ottimista, oggi traspare una rete di dubbi. C’è da dire che gli analisti americani sono concordemente convinti di questa analisi sino-catastrofica, la Cina è una tigre di carta e prima o poi prenderà fuoco (anche perché ci sono seri problemi nell’approvvigionamento idrico). Rimandiamo ad altre sede una conferma o meno di questa profezia, aggiungo solo che la Cina non ha mai preso del tutto fuoco in duemiladuecento anni e che suddetti analisti provengono da un paese che di anni ne ha solo poco più di duecento. Il confine tra la seria previsione ed il wishful thinking sconfinante nella macumba, temo sia molto labile.
L’India sembra più simpatica a Rampini che lì ha la figlia che svolge progetti di ricerca. Aperta al nuovo asse con Washington (ma temo sia un eccesso di obamismo da parte del genovese dar per scontato questo schieramento geopolitico), l’India è piena di luci e di ombre ma forse le luci prevalgono. Forse proprio perché essendo già di suo patria di un certo caos permanente, l’India sembra quantomeno non aver problemi di adattamento al nuovo clima confuso. Problemi ne ha: burocrazia, inquinamento, ineguaglianza, pessime infrastrutture, scuola di base quasi inesistente. In più il nuovo nazionalismo indù, le tensioni coi musulmani, la condizione della donne, le frizioni tra sistema democratico e sistema castale, anche se questo vige solo fuori dei grandi centri. Però è piena di giovani (sebbene dentro una marea demografica montante che la porterà a superare la Cina previdente del figlio unico), sprigiona innovazione ed è forte storicamente nell’intelligenza astratta (matematica), ha un’economia molto sviluppata all’interno e quindi risente meno degli scossoni del caos globale sebbene rimanga dipendente da i capitali esteri che il prossimo rialzo dei tassi Fed potrebbe spingere al ritiro. Interessante la segnalazione delle nuove tecnologie – jugaad –, tecnologie nate per costare molto poco e consumare meno. Forse questo è uno dei segnali positivi dal futuro, quando una piena molteplicità di sistemi, fornirà molteplicità di risposte. Vale per l’innovazione, vale per i sistemi economici, vale per i sistemi culturali, religiosi, politici.
Il report sull’ambiente riporta il problema dell’acqua, drammatico già in California e sul punto di esserlo in Cina e poi: l’acidificazione degli oceani, l’innalzamento delle acque, la riduzione di biodiversità, l’impoverimento dei terreni, la desertificazione, la rarefazione dei minerali e la prima o poi inevitabile fine delle energie fossili, insetti, virus, caldo, poca acqua o troppa acqua (dislocazione dei climi). Come si affronteranno le emergenze, come vivranno tali pressioni i garantiti dalla propria mobilità e ricchezza ed i fissi, i poveri? Guerre? Grandi balli geopolitici? Governi sempre più autoritari per gestire emergenze sempre più fuori scala? Come impatterà nella dinamica dei prezzi, soprattutto del cibo? Intanto, con raro acume, i repubblicani americani, promuovono la privatizzazione della protezione civile perché dalle disgrazie si traggono molti profitti e nel far profitti si risolvono tutti i problemi. De resto, c’era chi in piena Peste Nera credeva di risolvere il problema andando tutti in chiesa a pregare, cioè a scambiarsi le pulci portatrici dei batteri, per cui non stupiamoci troppo. Non siamo più così primitivamente stupidi, oggi la stupidità è scientifica.
La tecnologia è sempre più distruptive, in pieno senso schumpeteriano. Ma anche qui si proiettano ombre non proprio rassicuranti. L’erosione del lavoro umano, i rischi di creare un mondo-macchina di cui poi perderemo il controllo e che alla fine si riprodurrà da sé e senza neanche le tre leggi di Asimov, l’high-frequency trading che amplifica ogni battito di ali di farfalla scatenando tempeste su i mercati interconnessi, gli hacker ma soprattutto il fatto che tutto ciò è spinto o dal profitto o dall’interesse militare o da entrambi. Facebook capitalizza più di Walmart con 10.000 occupati contro 2,2 milioni che però vendono merci soprattutto cinesi, Google porta i profitti offshore assieme a molti altri. Reggerà un sistema che fa sempre più profitti con meno persone per poi sottrarli alla tassazione? Molte innovazioni, tutte praticamente, non si è ancora ben capito a cosa servono se non a erodere lavoro umano e quindi chissà chi avrà i soldi da mettere nel sistema che rischia per il profitto a breve, di privarsi di quello medio e lungo termine. Certo, c’è la scoperta che non è più necessario possedere le cose, che le si possono affittare alla bisogna, come gli uffici, ma anche questo è solo un adattamento alla scarsità della chiamata al lavoro per cui tante chiamate, spazi grandi e costi conseguenti, poche chiamate, spazi piccoli e licenziamenti. Il problema è che il primo caso mostra volumi e frequenze inferiori al secondo caso.
Questo pulsare nomadico della struttura di produzione scarica ansia e costi, diretti ed indiretti, tutti sulla popolazione lavorante mentre quella del profitto non mette mai piede sulla terra viscida e semovente, vola alto tra un QE e l’altro, tra un emergente e un riprendente, tra un abbassamento di tasse (e di tassi) ed un offshore, sempre che non si disaffezioni e magari vada a volare alto da qualche altra parte. Tra l’altro contribuendo sempre meno a quel welfare che sarebbe l’unica soluzione per reggere una tal scombinata forma di economia caotica. Ed a scanso di equivoci, l’élite predatoria (“estrattiva” secondo la definizione dei baldi Acemoglu-Robinson che la usano però in un diverso contesto) forma lobbies, finanzia partiti quando non scende direttamente in campo con i candidati, utilizza la sfera informativa e formativa per giustificare il suo modo che deve esser inteso come il migliore dei modi possibili e se subisce qualche rara ed occasionale sanzione, trova poi il modo di farla pagare a quelli stessi che sono intenti a salvar la propria esistenza dal caos permanente.
Senza arrivare a Piketty, addirittura Fukuyama censura questa finta democrazia, ormai, del tutto patrimonializzata. E il problema è certo più intenso lì dove il 4,4 per cento della popolazione mondiale ha il 22 per cento del PIL, negli Stati Uniti di House of Cards, della famiglie dinastiche, delle élite familiste e nepotiste, del marketing elettorale, dei circoli esclusivi e della ancora più esclusiva ed inaccessibile Ivy League, dei corpi della Stato che non si sa più bene a chi rispondano. Élite, il cui farsi sistema politico che ha in oggetto il controllo del mondo (certo non si fa il 22 per cento del PIL col 4,4 per cento della popolazione per le virtù intrinseche del proprio modello economico sebbene cialtroni prezzolati si prendano la briga di diffondere questa lieta novella dalla televisione, su i giornali, addirittura su i libri) spinge al nuovo imperialismo dei valori, a distruggere ogni sovranità politica, alle più ciniche alleanze con terroristi o dittatori, tenendo sempre a pieno regime il fatidico complesso scientifico-militar-industrial/commerciale di cui pur un generale, addirittura repubblicano, fattosi presidente (Eisenhower), denunciò l’invadenza totalitaria come suo lascito di saggezza alla nazione. Inascoltato.
Forse mi son fatto prendere un po’ la mano. Non è che Rampini certe informazioni o considerazioni non le faccia, magari non fa solo queste e mette a controcanto l’altra posizione, aggiungendovi colore ed una certa soavità narrativa. Però, anch’egli arriva a domandarsi: perché non ci si ribella? perché non ci sono nuove idee? Forse la seconda domanda spiega l’assenza di risposte per la prima.
Innanzitutto, il nostro pensiero, il pensiero che permette la presa di coscienza e la comunicabilità di questa presa è disadattato. È incredibile leggere la folta schiera degli intellettuali, anche quelli critici, che parlano di economia ma non di valute, di valute ma non di geopolitica, di geopolitica ma non di politica, di politica ma non di eserciti, di eserciti ma non di scienza, di scienza ma non di filosofia, di filosofia ma non di esseri umani e di mondo concreto. Così come la divisione del lavoro permette l’esistenza di un unico depositario del sapere del ciclo intero (il mercato), la divisione dei saperi permette l’esistenza di un concreto ciclo complesso di azioni e retroazioni la cui esistenza è però del tutto invisibile ai più.
La responsabilità più grossa di questo stato di cose è nel chi lo ha permesso. Lo ha permesso la minorità intellettiva di cui siamo tutti colpevoli sebbene i nostri maestri, quelli a cui ci siamo affidati in questi decenni per avere l’illuminazione della saggezza d’insieme, siano stati loro stessi presi nelle morse del riduzionismo, del determinismo, dell’idealismo astratto. Nell’esercizio della funzione critica, abbiamo tutti discusso i prodotti del pensiero ma non il metodo, il modo di produzione. E non parlo solo della denuncia dell’ideologia travestita, della non neutralità della scienza, dell’accademia serva ma proprio della forma del pensiero, semplice e limitato in frazioni sottodisciplinari, invece che complesso, ampio ad abbracciare quell’intero che Hegel pur aveva indicato come l’unico “vero”.
È chiaro dunque che le “nuove idee” non potranno essere figlie del vecchio metodo ed infatti la modernità iniziò con la discussione sul metodo, che fosse quella di Cartesio o quella di Galilei. Ed è chiaro che dalla revisione del metodo usciranno triturati sia i canoni dominanti il pensiero dominante, sia quelli dominanti il pensiero critico. In più, qui da noi in Occidente, è da vedere anche cosa far sopravvivere andando anche a ritroso della modernità, perché certe idee sono soggette a quella che Braudel (uno dei numi tutelari di questo blog) chiamava “lunga durata”. L’Occidente va incontro allo shock dell’adattamento ad un mondo di cui sarà una frazione tra le altre, da cui dipenderà ontologicamente, in cui ai vecchi servi non ci si potrà più rivolgere con la stessa forma e sostanza dei tempi fin qui trascorsi, in cui bisognerà accettare la reciprocità su cui si basa ogni interrelazione. Una orizzontalità a cui non siamo abituati. E non sarà solo necessaria una riconfigurazione della buona educazione ed un trionfo della big diplomacy, poiché quasi tutto del nostro modo di stare al mondo è dipeso e tuttora dipende da un certo modo di esercitare il controllo, nel senso di potere, sul resto del mondo. Perdendo progressivamente questo, tutta il nostro modo di stare al mondo perderà condizioni di possibilità.
È anche questa indisponibilità e resistenza alla messa in discussione radicale (da radici) a bloccare la nascita di nuove idee. L’oggetto di cui si parla, che sia un popolo, un modello di società, un modello di economia, uno Stato-nazione, un gruppo di Stati-nazione uniti da principi e modi simili (o addirittura comuni), è sempre un sistema. Un sistema non ha mai una sola causa ed ecco che il frazionamento disciplinare impedisce in via di principio proprio l’inquadramento ontologico, il dire di sistemi. Quando il sistema mostra decisi segnali di disadattamento al suo contesto, non è questa o quella sua parte che necessita di modifiche, è la sua stessa consistenza sistemica che va riformulata. Altresì, provenendo da tempi relativamente facili, quelli nei quali alimentammo la crescita del nostro tenore di vita estendendo il dominio sull’intero mondo, la nostra cultura sistemica è ancora “magica” com’è nell’incredibile concetto di “mano invisibile”. Dovremmo quindi non solo sviluppare una ontologia sistemica ma anche una architettonica, che è un sapere di cui siamo totalmente privi. Se non ci si apre alla discussione dell’intero partendo dalle sue radici, se cioè non si inaugura un nuovo metodo e non ci si dispone in senso demiurgico a rifare tutto d’accapo (magari poi usando anche pezzi vecchi ma assemblandoli diversamente), il problema non si sbloccherà. Una nuova era presuppone nuovi sistemi di idee e nuovi sistemi di vita associata, gli uni derivati dagli altri. Questo “nuovo radicale” è evocato dall’inflazione di “neo & post” con cui etichettiamo idee figlie di metodi che hanno tre secoli se non di più. Ma non è con l’aggettivazione che risolveremo il problema.
Leggere Rampini? Beh, dipende dallo stato delle conoscenze del lettore. Se si cerca l’analisi profonda dei fenomeni complessi o anche solo qualche squarcio di possibilità derivata magari proprio dal pensiero complesso, senz’altro no. Se si vuole re-incollare spezzoni di informazione che ognuno di noi incontra su Internet e su nomadiche e rapsodiche letture, non saprei. Rampini ha scritto un aggregato non ha disegnato un sistema, sebbene qualche suggerimento su come incollare i pezzi lo ha messo, qui e lì. Credo Rampini propenda per la parte di chi vuol salvare il capitalismo da se stesso. Questa idea, pare dall’assunto che noi si sia presenti ad una “degenerazione” ma non strutturale, bensì episodica, un cedimento da correggere. La sua interpretazione sistemica quindi prevede aggiustamento non rifondazione. Questa posizione non credo comprenda la radicalità della problematica in cui ci troviamo. Per gli altri, direi di sì. Non c’è tutto ma di tutto, la lettura è garbata, alcuni sguardi specie su India e nuove tecnologie sono utili, la lista delle componenti caotiche mostra una sforzo relativamente competente o comunque, senza dubbio, ben informato. Sebbene solo propedeutico ad un metodo complesso, meglio il patchwork di Rampini di tanti manualisti da “ora vi spiego io qual è il problema”.
Per le soluzioni, comunque, la strada è ancora lunga, molto lunga, e come sempre ricordiamo in questo spazio, il tempo è poco, molto poco.
Pubblicato sul blog dell’autore il 19 ottobre 2015.
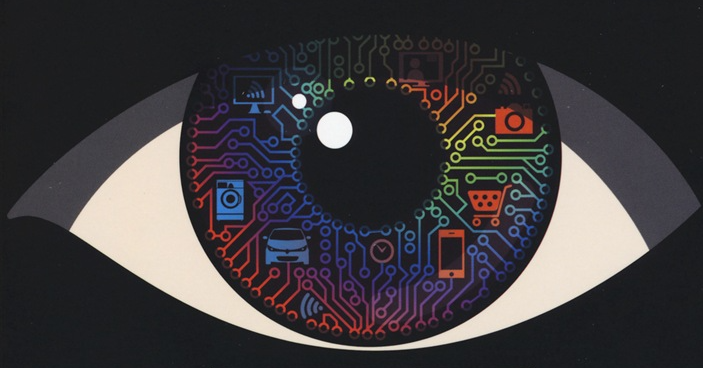


![Una donna controlla le informazioni sul cibo specificate sulla confezione [foto: archivio]](https://www.eunews.it/wp-content/uploads/2014/12/Etichette-alimentari.jpg)


![Ragazza in biblioteca. Nell'Ue chi studia non lavora e neppure cerca. In Italia funziona ancor più così [foto: Tulane University, Wikimedia Commons]](https://www.eunews.it/wp-content/uploads/2024/11/Girl_in_the_Library_3638661587-350x250.jpg)



