di Louis Menand
Il 24 febbraio 1848, a Londra, venne pubblicato un pamphlet di 23 pagine. Vi veniva affermato che l’industria moderna aveva rivoluzionato il mondo. Aveva superato, nel suo compimento, tutte le grandi civiltà del passato – le piramidi egizie, gli acquedotti romani, le cattedrali gotiche. Le sue innovazioni – le ferrovie, le navi a vapore, il telegrafo – avevano liberato fantastiche forze produttive. Nel nome del libero mercato, essa aveva abbattuto i confini nazionali, abbassato i prezzi, reso il pianeta interdipendente e cosmopolita.
I beni e le idee circolavano ormai ovunque. Allo stesso modo, aveva spazzato via tutte le vecchie gerarchie e mistificazioni. La gente non credeva più che erano la tradizione o la religione a determinare la loro condizione di vita. Ciascuno era, rispetto a chiunque altro, uguale. Per la prima volta nella storia, gli uomini e le donne potevano vedere, senza illusioni, la loro posizione in relazione agli altri. I nuovi modi di produzione, comunicazione e distribuzione avevano anche creato un enorme ricchezza. Ma c’era un problema. La ricchezza non veniva distribuita equamente. Il 10% della popolazione possedeva praticamente tutta la proprietà; il restante 90% non possedeva nulla. Come le città si industrializzavano, così la ricchezza veniva a concentrarsi, e come il ricco diveniva più ricco, la classe media cominciava a scivolare al livello della classe lavoratrice. Di fatto, presto ci sarebbero stati solo due tipi di persone nel mondo: quelli che detenevano proprietà e quelli che vendevano a questi il loro lavoro. Con lo scomparire delle ideologie che facevano apparire l’inuguaglianza naturale e ordinata, era inevitabile che i lavoratori avrebbero ovunque visto il sistema per ciò che era e si sarebbero levati per rovesciarlo. Lo scrittore che fece tale previsione fu, naturalmente, Karl Marx, e il pamphlet era Il Manifesto del Partito Comunista. Tale previsione è ancora valida oggi.
In considerazione della sua rilevanza, piuttosto folgorante, per la politica di oggi, sorprende che due importanti libri su Marx tentino invece di ricacciarlo nel suo secolo. «Marx non è stato nostro contemporaneo», dice Jonathan Sperber in Karl Marx: A Nineteenth-Century Life, uscito nel 2013; è più «una figura del passato che un profeta del presente». E Gareth Stedman Jones spiega che l’obiettivo del suo nuovo libro, Karl Marx: Greatness and Illusion, è «collocare Marx nell’ambito del diciannovesimo secolo».
Il compito ha una sua valenza. Storicizzare – correggere la tendenza ad attualizzare il passato – è ciò che fanno gli studiosi. Sperber, che insegna all’università del Missouri, e Stedman Jones, che insegna all’università Queen Mary di Londra ed è co-direttore del Centro di storia ed economia all’università di Cambridge, fanno entrambi un lavoro eccezionale nel radicare Marx nella vita politica e intellettuale europea del diciannovesimo secolo.
Marx è stato uno dei più grandi polemisti di sempre: molti dei suoi scritti riguardano personaggi ed eventi marginali e per lo più dimenticati. Sperber e Stedman Jones mostrano entrambi che se si legge Marx in quel contesto, come un uomo impegnato in una guerra politica e filosofica senza fine, l’importanza dei passi più conosciuti dei suoi scritti può risentirne. La posta in gioco sembra più ristretta. In fondo, il loro Marx non è molto diverso dal Marx conosciuto, ma è più vittoriano. L’aspetto interessante è che, data la similitudine dei loro approcci, non c’è fra loro molta distanza.
Inoltre, Marx è stato anche ciò che Michel Focault chiamò l’iniziatore di un discorso. Un enorme corrente di pensiero è chiamata col suo nome. «Non sono un marxista», si dice che abbia detto, ed è importante distinguere ciò che egli voleva dire dall’uso che altri hanno fatto dei suoi scritti. In effetti, molto del significato del suo lavoro si trova nei suoi effetti. Comunque egli abbia gestito la situazione, e nonostante il fatto che, come dimostrano Sperber and Stedman Jones, egli possa sembrare, in qualche modo, come l’ennesimo teorizzatore di sistemi novecentesco, Marx produsse lavori che hanno conservato nel tempo la loro potenza di fuoco. Ancora oggi, il Manifesto comunista è come una bomba che può sfuggire di mano.
E, diversamente da molti critici del capitalismo industriale del diciannovesimo secolo – e ce n’erano tanti – Marx era un vero rivoluzionario. Tutto il suo lavoro è stato scritto per servire la rivoluzione che aveva predetto nel Manifesto comunista e che era certo sarebbe giunta. Dopo la sua morte, ci sono state rivoluzioni comuniste – anche se non dove e come egli aveva immaginato, ma comunque nel suo nome. Alla metà del ventesimo secolo oltre un terzo della gente nel mondo viveva sotto regimi che si chiamavano, e veramente credevano di essere, marxisti.
Questo è importante, perché uno dei principi chiave di Marx era che la teoria deve essere sempre unita alla pratica. È questo il punto della famosa undicesima tesi su Feuerbach: «I filosofi hanno finora soltanto interpretato il mondo in alcuni modi; il punto è cambiarlo». Marx non stava dicendo che la filosofia è irrilevante; stava dicendo che i problemi filosofici emergono dalle condizioni di vita reale, e possono essere risolti solo cambiando quelle condizioni – rifacendo il mondo. E le idee di Marx furono impiegate per rifare il mondo, o una gran parte di esso. Anche se nessuno lo può considerare responsabile, in senso giuridico, per il risultato, in base al principio stesso di Marx il risultato ci dice qualcosa circa le sue idee.
In breve, si può ricollocare Marx nel diciannovesimo secolo, ma non lo si può lasciare lì. Egli perse un sacco di tempo a litigare con i rivali e ad accendere la miccia di fuochi settari, senza nemmeno finire il lavoro che considerava il suo magnum opus, Il Capitale. Ma, nel bene o nel male, non si può ritenere obsoleto il suo pensiero. Vide che le economie di libero mercato, lasciate ai loro meccanismi, producono grandi ineguaglianze, e trasformò un metodo di analisi che risaliva a Socrate – capovolgendo concetti che crediamo di comprendere e diamo per scontati – in una risorsa per afferrare le condizioni sociali ed economiche delle nostre vite. Eccettuato il suo, per tutta la vita, fedele collaboratore, Friedrich Engels, quasi nessuno aveva indovinato, nel 1883, l’anno della sua morte a 64 anni, quale sarebbe stata la sua influenza. Al funerale andarono undici persone. Per quasi tutta la sua carriera, Marx fu una stella in una piccola costellazione di esiliati radicali e rivoluzionari falliti (con spie della polizia e la censura a tenerli d’occhio) ma quasi sconosciuto al di fuori di essa. I libri per cui è famoso non furono proprio dei best sellers. Il Manifesto comunista sparì quasi subito dopo la pubblicazione e non fu quasi mai ristampato per 24 anni; quando il primo volume del Capitale uscì , nel 1867, fu praticamente ignorato. Dopo quattro anni, aveva venduto un migliaio di copie, e non venne tradotto in inglese fino al 1886.
Il secondo e il terzo volume del Capitale furono pubblicati dopo la morte di Marx, riuniti da Engels fra centinaia di pagine di bozze (Marx scriveva incredibilmente male; Engels era uno dei pochi al di fuori della famiglia in grado di decifrarlo). Le Tesi su Feuerbach, che Marx scrisse nel 1845, furono scoperte solo nel 1888, quando Engels le pubblicò, e alcuni dei testi più importanti per i marxisti del ventesimo secolo – il volume collettaneo noto come L’ideologia tedesca, i cosiddetti manoscritti parigini del 1844 e il libro intitolato I Gundrisse, edito dai sovietici – rimasero sconosciuti fino al 1920 e oltre. Sembra che Marx non abbia considerato tale materiale come pubblicabile.
In tutta la vita di Marx, il lavoro che portò finalmente l’attenzione fuori dalla sua cerchia ristretta fu un articolo di 35 pagine chiamato “La guerra civile in Francia”, uscito nel 1871, nel quale salutò la breve e violentemente soppressa Comune di Parigi come «la gloriosa precorritrice di una nuova – cioè, comunista – società». Non si tratta di un testo molto citato al giorno d’oggi.
Una ragione per cui Marx rimase relativamente in ombra è che solo verso la fine della sua vita i movimenti per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori cominciarono a ottenere qualcosa in Europa e negli USA. Nella misura in cui quei movimenti erano riformisti piuttosto che rivoluzionari, non erano marxisti (anche se Marx, in tarda età, contemplò la possibilità di una transizione pacifica al comunismo). Con la crescita del movimento dei lavoratori crebbe l’attenzione verso il pensiero socialista e, con ciò, l’interesse per Marx.
Eppure, come Alan Ryan scrive nella sua caratteristicamente lucida e concisa introduzione al pensiero politico di Marx, Karl Marx: Revolutionary and Utopian, se Vladimir Lenin non fosse giunto a Pietrogrado nel 1917 e non avesse preso la guida della rivoluzione russa, Marx sarebbe oggi probabilmente conosciuto come «un filosofo, sociologo, economista e teorico politico minore del diciannovesimo secolo». La rivoluzione russa fece prendere al mondo sul serio la critica di Marx al capitalismo. Dopo il 1917, il comunismo non era più una fantasia utopica.
Marx è un monito di ciò che può accadere quando si sfidano i genitori e si ottiene un dottorato in filosofia. Il padre di Marx, un avvocato della cittadina di Treviri, nella Germania occidentale, aveva cercato di farlo iscrivere a legge, ma Marx scelse filosofia. Studiò all’università Friedrich-Wilhelms, dove aveva insegnato Hegel, e diventò membro di un gruppo di intellettuali, i giovani hegeliani. Hegel era cauto riguardo alla critica verso la religione e lo Stato prussiano; i giovani hegeliani non lo erano, e, proprio quando Marx si laureò, nel 1841, ci fu una repressione nei loro confronti. Il mentore di Marx fu licenziato, e i giovani hegeliani diventarono i paria dell’accademia. Così Marx fece ciò che fanno molti disoccupati laureati in filosofia: si diede al giornalismo.
A parte qualche breve libro, il giornalismo era per Marx la sola fonte di reddito. Una storiella, secondo Sperber infondata, dice che una volta, per la disperazione, trovò un lavoro come impiegato alle ferrovie, ma lo perse per la pessima calligrafia. Nel decennio del 1840, Marx collaborò con vari giornali politici europei; fra il 1852 e il 1862, scrisse per il New York Daily Tribune, il giornale all’epoca più diffuso nel mondo.
Quando il lavoro di giornalista venne a mancare, fu in difficoltà. Dipendeva spesso dall’aiuto di Engels e da anticipi sull’eredità. Talvolta rimase senza cibo; a un certo punto, non poté uscire di casa perché aveva impegnato l’unico cappotto. L’affermazione che fosse incapace di gestire le finanze, e che lui e sua moglie sperperavano i pochi soldi nei lussi della classe media come la musica o le lezioni private per i figli, divenne una tipica “contraddizione” riportata nelle biografie su Marx. Sperber non è d’accordo. Marx aveva meno soldi da sprecare di quanto riportato dagli storici, e si rassegnò alla povertà quale prezzo per la sua attività politica. Avrebbe anche vissuto in un sobborgo, ma non volle che la sua famiglia soffrisse. Tre dei figli morirono giovani e un quarto nacque morto; la povertà e le condizioni di vita potrebbero esserne state le cause.
L’attività giornalistica di Marx ne fece sempre un esule. Scrisse e pubblicò articoli offensivi per le autorità, e, nel 1843, venne espulso da Colonia, dove stava partecipando alla diffusione del Rheinische Zeitung (‘La gazzetta renana’). Andò a Parigi, dove vi era un’ampia comunità tedesca, e dove fece amicizia con Engels. Avevano avuto un primo incontro a Colonia, ma quando si rincontrarono al Café de la Régence, nel 1844, passarono dieci giorni senza smettere di parlare.
Engels, di due anni più giovane, aveva le stesse idee politiche di Marx. Ben presto, dopo il loro incontro, scrisse il suo classico La condizione della classe operaia in Inghilterra, che terminava con la predizione di una rivoluzione comunista. Il padre di Engels era un industriale tedesco del settore tessile, con fabbriche a Barmen, Brema e Manchester, in Inghilterra, e anche se disapprovava le idee politiche del figlio e le sue compagnie, gli diede un posto nella fabbrica di Manchester. Engels odiava quel lavoro anche se lo sapeva fare, così come era capace in molte altre cose. Andava a caccia di volpi con gente che disprezzava e si divertiva quando Marx cercava di cavalcare. Alla fine Engels divenne un socio della società, e con il suo reddito aiutò Marx a sopravvivere.
Nel 1845 Marx fu espulso dalla Francia. Andò a Bruxelles. Tre anni dopo, accadde qualcosa che quasi nessuno aveva previsto: scoppiarono diverse rivoluzioni in giro per l’Europa, incluso in Francia, Italia, Germania e nell’impero austriaco. Marx scrisse il Manifesto comunista nel pieno delle sollevazioni. I moti arrivarono a Bruxelles ed egli, sospettato di fomentare rivolte armate, fu espulso dal Belgio, ma tornò a Parigi. Lì i rivoltosi avevano invaso le Tuileries e dato fuoco al trono di Francia.
Verso la fine dell’anno, la maggior parte dei moti erano stati soffocati dalle forze monarchiche. Molti personaggi che erano o sarebbero diventati figure importanti dell’arte e della letteratura – Wagner, Dostoevskij, Baudelaire, Turgenev, Berlioz, Delacroix, Liszt, George Sand – erano rimasti coinvolti nel sentimento rivoluzionario, e il risultato fu una crisi di fiducia nella politica (l’argomento della novella L’educazione sentimentale di Flaubert).
Il fallimento delle rivoluzioni del 1848 fece dire a Marx la frase «la prima volta come tragedia, la seconda come farsa» (che sentì da Engels). La tragedia era stato il destino della rivoluzione francese sotto Napoleone; la farsa fu l’elezione del nipote, Luigi Napoleone Bonaparte, che Marx considerava un inetto, alla presidenza della Francia, nel dicembre 1848. Bonaparte arrivò a dichiararsi imperatore e regnò fino al 1870, quando la Francia perse la guerra con la Prussia. La Comune di Parigi fu una conseguenza della guerra.
Così, nel 1849, Marx fu costretto all’esilio ancora una volta. Portò la sua famiglia a Londra. Pensava di restarci temporaneamente, ma ci visse per il resto dei suoi giorni. È lì che, giorno dopo giorno, nella sala di lettura del British Museum, compì la ricerca per Il Capitale, ed è lì che è sepolto, al cimitero di Highgate. Il busto di bronzo che tuttora si trova sulla sua lapide fu installato nel 1956 dal Partito Comunista della Gran Bretagna.
Che sembianze aveva Marx? Non ci sono molti resoconti, ma essi tendono a convergere. Era, in un certo senso, una caricatura dell’accademico tedesco (il che una volta aveva sperato di diventare): un imperioso “so tutto”, con i capelli arruffati, in un lungo cappotto sbottonato. Una volta si descrisse a suo figlio come «una macchina condannata a divorare libri per rigettarli, in un’altra forma, nel letamaio della storia». Scriveva tutta la notte fra le nuvole di fumo del tabacco, circondato da pile di libri e giornali. «Sono i miei schiavi», disse, «e mi servono all’occorrenza».
Dal lato professionale, era da evitare. Parlava senza sosta ma balbettava e non era un buon oratore; lo sapeva, e di rado si presentava in pubblico. Quando scriveva era spietato, si fece nemici molti amici e alleati, e non sopportava gli stupidi – che erano poi quasi tutti quelli che conosceva, dal suo punto di vista. Un esule tedesco lo descrisse come «un intellettuale che ingaggia agenti e guardie di confine, per preservare la sua autorità».
Eppure incuteva rispetto. Un collega, ricordando Marx a 28 anni, lo descrisse come «un leader di popolo nato». Sapeva tenere la scena – come editore, e, più avanti, come la figura dominante della Associazione internazionale dei lavoratori, la Prima Internazionale. Aveva i capelli e gli occhi neri; la carnagione scura. Engels lo chiamava il nero di Treviri; la moglie e i figli lo chiamavano il moro.
Nel privato, era modesto e gentile. Quando non stava male – aveva il fegato malandato, soffriva di bronchite e gli erano venuti dei grossi foruncoli, che Sperber pensa fossero causati da un disordine autoimmunitario, forse sintomo della malattia al fegato – era giocoso e affettuoso. Amava Shakespeare, inventava storie per le tre figlie, e si godeva i sigari economici e il vino rosso. La moglie e le figlie lo adoravano. Un agente del governo prussiano che andò nel 1852 a casa di Marx rimase sorpreso di trovare «il più gentile e mite degli uomini».
A diciotto anni si era fidanzato con la ventiduenne Jenny von Westphalen, anch’ella di Treviri. Sperber crede che sia sorta una favola intorno al matrimonio, con Jenny eccezionalmente bella e devota a Karl. Lui le scriveva poesie d’amore appassionato. Il fidanzamento durò sette anni, durante i quali lui finì gli studi e raramente si videro. La relazione fu prevalentemente epistolare (Sperber pensa che ci siano stati rapporti prematrimoniali). Nelle sue lettere, Jenny chiama Karl il suo «piccolo cinghiale selvaggio».
L’unico possibile neo nell’idillio domestico riguarda la bambina avuta dalla loro serva, Helene Demuth. Helene era un dono ai Marx ricevuto dalla madre di Jenny e viveva con la famiglia (nel diciannovesimo secolo in Inghilterra era una consuetudine per quasi tutte le donne che potevano permettersela. Persino Miss Bates, nell’Emma di Jane Austen, che viveva della carità dei vicini, aveva una serva). La bambina di Helene, Frederick, chiamata Freddy, nacque nel 1851 e fu allevata da genitori adottivi.
La figlia di Marx non lo vide fino alla sua morte. Engels ne rivendicò la paternità. Ciò non è implausibile. Engels non era sposato e le piacevano le donne della classe lavoratrice; la sua amante, Mary Burns, lavorava in una fabbrica di Manchester. Pare tuttavia che, 44 anni dopo, sul letto di morte, abbia detto che Marx era il vero padre di Freddy, un informazione poi giunta nei circoli comunisti ma resa pubblica solo nel 1962. Sperber e Stedman Jones accettano la storia, come aveva fatto il biografo David Mc Lellan, anche se un biografo di Engels, Terrell Carver, pensa che le prove non siano univoche. La Demuth rimase con la famiglia; dopo la morte di Marx, andò a lavorare per Engels. E il matrimonio di Marx sopravvisse.
È la loro comprensione di Marx che spinge Sperber e Stedman Jones a insistere per una sua lettura relativa al contesto del diciannovesimo secolo, perché essi cercano di distinguerlo dall’interpretazione del suo lavoro fattane dopo la morte da persone come Karl Kautsky, che ne fu il massimo esponente di lingua tedesca; Georgi Plekhanov, il massimo esponente di lingua russa; e, fra tutti il più influente, Engels. È stato soprattutto grazie a questi scrittori che la gente ha cominciato a riferirsi al marxismo come al “socialismo scientifico”, una frase che compendia ciò che era più temuto del comunismo nel ventesimo secolo: l’idea che gli esseri umani possano essere ripensati secondo una teoria che si presenta come una legge della storia.
Così, nel 1939, quando il filosofo Britannico Isaiah Berlin pubblicò il suo ampiamente letto e non completamente apprezzato studio Karl Marx: His Life and Environment (ancora in stampa), poté descrivere Marx come «uno dei grandi e autorevoli fondatori di nuove fedi, spietato sovvertitore e innovatore che interpretò il mondo in termini di un solo chiaro, appassionato e solido principio, denunciando e distruggendo tutto ciò che con esso confligge. La sua fede… era di quelle senza limiti, di un tipo assoluto che mette fine a tutte le domande e a tutte le difficoltà». Questo divenne il Marx della guerra fredda.
È vero che Marx era molto dottrinario, qualcosa che non si sposava con i suoi compatrioti del diciannovesimo secolo, e che non di certo non si sposa bene col pensiero di oggi, dopo che l’esperienza dei regimi concepiti in suo nome. Sembra perciò sbagliato dire che la filosofia di Marx era rivolta alla libertà dell’umanità. Eppure lo era. Marx era un pensatore illuminato: voleva un mondo razionale e trasparente, nel quale gli esseri umani fossero liberati dal controllo di forze esterne.
Era l’essenza dell’hegelismo di Marx. Hegel aveva argomentato che la storia è il progresso dell’umanità verso la vera libertà, che intendeva come autocontrollo e autocomprensione, visione del mondo senza illusioni – illusioni che noi stessi creiamo. L’esempio controverso di questo era, per i giovani hegeliani, il Dio cristiano (è ciò che scrisse Feuerbach). Abbiamo creato Dio, e poi crediamo che Dio ci abbia creati. Abbiamo ipostatizzato il concetto di noi stessi e lo abbiamo trasformato in qualcosa “là fuori” i cui comandamenti (fatti da noi) ci sforziamo di capire per obbedirvi. Siamo supplicanti della nostra stessa finzione.
Concetti come Dio non sono errori. La storia è razionale: c’è una ragione per cui creiamo il mondo in un certo modo. Abbiamo inventato Dio perché Dio ci risolvesse certi problemi. Ma, una volta che un concetto comincia a impedirci il progresso verso l’autocontrollo, deve essere criticato e messo da parte. Altrimenti, come i membri dell’odierno Stato Islamico, diventiamo strumento del nostro Strumento.
Quello che rende difficile mettere via gli strumenti che abbiamo oggettivato è la persistenza delle ideologie che li giustificano, e che fanno apparire un’invenzione dell’uomo come “lo stato delle cose”. Il compito della filosofia è disfare le ideologie. Marx era un filosofo. Il sottotitolo del Capitale è “Critica dell’economia politica”. Il libro, rimasto incompleto, era inteso come una critica ai concetti economici che facevano sembrare le relazioni sociali in un’economia di libero mercato naturali e inevitabili, così come concetti quali la grande catena dell’essere e il diritto divino dei re facevano una volta sembrare le relazioni sociali del feudalesimo naturali e inevitabili.
La ragione per la quale Il Capitale sembra più un lavoro di economia che un lavoro di filosofia – la ragione per cui è pieno di tabelle e grafici anziché di sillogismi – è la stessa data dalle undici tesi su Feuerbach: lo scopo della filosofia è capire le condizioni per cambiarle. Marx diceva che quando aveva letto Hegel aveva trovato che la sua filosofia si poggiava sulla testa, così l’aveva capovolta e posizionata perché poggiasse sui piedi.
La vita è azione, non pensiero. Non basta essere padroni della nostra poltrona. Marx credeva anche che il capitalismo industriale fosse stato creato per una buona ragione: aumentare la ricchezza economica – un qualcosa che Il Manifesto comunista vede favorevolmente. Tuttavia, il costo è un sistema in cui una classe di esseri umani, i proprietari (la borghesia, nei termini di Marx) sfrutta un’altra classe, i lavoratori (il proletariato).
I capitalisti non si comportano così perché sono avidi o crudeli (anche se possono essere descritti in tal modo, come Marx fece quasi sempre). Si comportano così perché è la competizione a richiederlo. È così che funziona il sistema. Il capitalismo industriale è un mostro di Frankenstein che minaccia il suo creatore, un sistema costruito per i nostri scopi e che ora ci controlla.
Marx era un umanista. Credeva che siamo esseri che trasformano il mondo che ci circonda per la produzione di oggetti a beneficio di tutti. Il che è la nostra essenza come specie. Un sistema che trasforma questa attività in “lavoro” che viene comprato e usato per arricchire altri è un ostacolo alla piena realizzazione della nostra umanità. Il capitalismo è destinato all’autodistruzione, proprio come i sistemi economici che l’hanno preceduto. La rivoluzione della classe lavoratrice condurrà allo stadio finale della storia: il comunismo, che, come scritto da Marx, «è la soluzione all’enigma della storia e si riconosce come tale soluzione».
Marx fu fanaticamente impegnato nel trovare una corroborazione empirica a questa teoria. È questo che intendeva con posizionare la filosofia in modo che essa poggi sui piedi. Ed ecco perché passò tutte quelle ore, solo, al British Museum, a studiare rapporti sui fattori di produzione, dati sulla produzione industriale, statistiche sul commercio internazionale. Era un eroico tentativo di mostrare che la realtà è allineata alla teoria. Non importa se non riuscì a finire il libro.
Marx ebbe poco da dire sulla conduzione dell’economia in una società comunista, e questo diventò un serio problema per i regimi che hanno cercato di mettere il comunismo in pratica. Aveva diverse ragioni per restare vago. Credeva che i nostri concetti, valori e credenze emergessero dalle condizioni del nostro tempo, il che vuol dire che è difficile conoscere cosa c’è dietro un mutamento storico. In teoria, dopo la rivoluzione, tutto si sarebbe potuto “afferrare” – il che è diventato da allora il grande sogno del radicalismo di sinistra.
Marx è stato chiaro circa le cose che una società comunista non dovrebbe avere. Non ci dovrebbe essere un sistema di classi, niente proprietà privata, niente diritti individuali (che, secondo Marx, sono confezionati per proteggere il diritto dei proprietari del capitale a mantenerlo) e niente Stato (che definiva come «un comitato per la gestione degli affari della borghesia»). Lo Stato, sotto forma di partito, si è dimostrato un concetto borghese dal quale i regimi comunisti del ventesimo secolo non hanno potuto trascendere. Il comunismo non è una religione; è in realtà, come solevano dire gli anticomunisti, senza Dio. Ma il partito funziona nel modo in cui Feuerbach diceva che Dio funziona nel cristianesimo: come un misterioso e implacabile potere esterno.
Marx non predispose, comunque, una guida per come dovrebbe operare una società senza classi o senza Stato. Un buon esempio del problema è la sua critica alla divisione del lavoro. Nel primo capitolo della Ricchezza delle nazioni, nel 1776, Adam Smith identificò la divisione del lavoro – cioè la specializzazione – come la chiave della crescita economica. L’esempio di Smith era la fabbricazione degli spilli. Piuttosto che far fare a un singolo lavoratore uno spillo alla volta, diceva Smith, in una fabbrica si può dividere il lavoro in diciotto operazioni distinte, dal filo fino al confezionamento, e incrementare la produzione di un fattore di migliaia.
A noi ciò sembra un ovvio sistema per organizzare efficientemente il lavoro, dalle catene di montaggio delle automobili fino alla “produzione di conoscenza” nelle università. Ma Marx considerò la divisione del lavoro uno dei mali della vita moderna (come aveva fatto Hegel). Essa fa dei lavoratori ingranaggi di una macchina e li priva di qualsiasi collegamento con il prodotto del loro lavoro. «L’azione dell’uomo diventa una forza aliena ad egli opposta, che lo rende schiavo invece di essere da egli controllata», come Marx ebbe a dire. In una società comunista, scrisse, «nessuno ha una sfera esclusiva di attività ma ciascuno può realizzarsi in ogni campo che desidera«. Sarà possibile «andare a caccia la mattina, pescare il pomeriggio, badare al bestiame la sera, fare il critico dopo cena… senza essere necessariamente cacciatore, pescatore, mandriano o critico».
Questa frase, spesso citata, sembra superficiale, ma va al cuore del pensiero di Marx. Gli esseri umani sono, per natura, creativi e socievoli. Un sistema che li tratta come monadi meccaniche è inumano. Ma la domanda è: come potrebbe una società senza divisione del lavoro produrre una quantità sufficiente di beni per vivere? Nessuno vorrà badare al bestiame (o pulire il granaio); ognuno vorrà essere un critico (credetemi). Come Marx ammise, il capitalismo, con tutti i suoi mali, ha creato l’abbondanza. Sembra che egli abbia immaginato, in qualche modo, che tutte le caratteristiche del modo di produzione capitalistico potrebbero essere messe da parte e l’abbondanza persistere magicamente.
Nel 1980, il filosofo Peter Singer pubblicò un breve libro su Marx nel quale elencò alcune delle profezie di quest’ultimo: la differenza di reddito fra i lavoratori e i proprietari sarebbe cresciuta, i produttori indipendenti sarebbero stati assorbiti nei ranghi del proletariato, i salari sarebbero rimasti a livelli di sussistenza, il tasso di profitto sarebbe crollato, il capitalismo sarebbe collassato, e allora vi sarebbe stata la rivoluzione nei paesi avanzati. Singer pensò che la maggior parte di tali predizioni fossero «così palesemente errate» che era difficile capire come qualcuno potesse difenderle. Ma, nel 2016, è più difficile liberarsene così sbrigativamente.
«Gli economisti di oggi farebbero bene a trarre ispirazione dal suo esempio», Thomas Piketty dice di Marx, nel suo best-seller del 2013 Il capitale del ventunesimo secolo. Il libro fa per molti lettori del ventunesimo secolo ciò che Marx sperava che Il Capitale avrebbe fatto per quelli del diciannovesimo secolo. Usa i dati per mostrare la vera natura delle relazioni sociali e, così facendo, ci costringe a ripensare concetti che erano arrivati a sembrare naturali e inevitabili.
Uno di questi è il concetto che il mercato, spesso immaginato come un meccanismo auto-ottimizzante con cui è sbagliato interferire, è, di fatto, lasciato a se stesso, un sistema che accresce in continuazione le inuguaglianze. Un altro concetto, strettamente connesso, è la meritocrazia, che è spesso vista come una garanzia della mobilità sociale ma che, Piketty dimostra, è utile principalmente ai vincitori della competizione economica per sentirsi virtuosi.
Piketty dice che per trent’anni, dopo il 1945, un elevato tasso di crescita nelle economie avanzate è stato accompagnato da una crescita dei redditi della quale hanno beneficiato tutte le classi. Gravi ineguaglianze di ricchezza erano arrivate a sembrare qualcosa del passato (il che spiega perché, nel 1980, la gente poteva con una certa ragionevolezza dire che le predizioni di Marx erano errate). Oggi pare che quei trent’anni siano stati una fase anomala. La Depressione e le due guerre mondiali avevano effettivamente messo fuori gioco i proprietari della ricchezza, ma i trent’anni dopo il 1945 hanno resettato l’ordine economico.
«Il livello molto elevato della ricchezza privata che è stato raggiunto a cominciare dagli anni ottanta e novanta del ’900 nei paesi più ricchi d’Europa e in Giappone», dice Piketty, «riflette direttamente la logica marxiana». Marx era nel giusto quando diceva che non esiste alcun egualitarismo naturale nelle moderne economie lasciate a se stesse. Come scrive Piketty, «non c’è alcun processo naturale o spontaneo che impedisca alle destabilizzanti forze inegualitarie di prevalere permanentemente».
La tendenza del sistema ad accrescere le ineguaglianze era certamente vera nel secolo di Marx. Nel 1900, l’un per cento più ricco della popolazione in Gran Bretagna e Francia possedeva più del 50% della ricchezza; il 10% più ricco ne possedeva il 90%. Oggi ci stiamo riavvicinando a quegli stessi livelli. Secondo la Federal Reserve, il 10% più ricco della popolazione possiede il 72% della ricchezza, e il 50% della popolazione più povera ha il 2% del totale. Circa il 10% del reddito nazionale va alle 247.000 persone più ricche (un millesimo della popolazione adulta).
Non è un problema limitato alle nazioni ricche. Anche la ricchezza globale è distribuita in modo iniquo, e nelle stesse proporzioni se non peggio. Piketty non predice una rivoluzione mondiale della classe lavoratrice; sottolinea l’insostenibilità di questo livello di ineguaglianza. Prevede un mondo dove la maggior parte del pianeta è posseduto dai miliardari. Marx non sbagliava neppure riguardo alla tendenza dei salari dei lavoratori a ristagnare mentre il reddito dei proprietari di capitale aumenta. Nei primi 60 anni del diciannovesimo secolo – il periodo durante il quale cominciò a scrivere Il Capitale – le retribuzioni dei lavoratori in Gran Bretagna e Francia rimasero più o meno fermi a livelli di sussistenza. Può essere difficile, ora, concepire il grado di miseria presente nell’economia del diciannovesimo secolo. Nel 1862, l’orario di lavoro medio settimanale in una fabbrica di Manchester era di 84 ore.
La stagnazione dei salari sembra tornata. Dopo il 1945, i salari aumentarono insieme al reddito nazionale, ma il reddito dei percettori di livello più basso raggiunse il picco nel 1969, quando il salario minimo orario negli USA era $1,60. Ciò equivale a $10,49 di oggi, quando il salario minimo è $7,25. E, mentre i salari nel settore dei servizi diminuiscono, l’orario di lavoro settimanale aumenta, perché la gente è obbligata a fare più di un lavoro.
La retorica del nostro tempo, il tempo di Bernie Sanders e Donald Trump, la Brexit e le tensioni in Europa, sembra avere un cast marxista. Sanders che propone di ridurre l’ineguaglianza, così come Piketty, tassando la ricchezza e garantendo più accesso all’istruzione. Trump, che ammira personalità autoritarie e che potrebbe essere lieto di sapere che Marx appoggiava il libero commercio sulla base della teoria che abbassando i salari, il libero commercio incrementa la povertà della classe lavoratrice e conduce più velocemente alla rivoluzione. Nei termini odierni, usati a sinistra, a destra e sui giornali: il sistema è “truccato” per favorire “le élite”. Marx la chiamava classe dominante.
Quanto può essere utile Marx per comprendere la bolla di fermento nelle economie avanzate? Credo che ancora non si conosca il preciso profilo demografico di coloro che hanno votato per la Brexit e dei sostenitori di Trump e Sanders – se si tratti di persone danneggiate effettivamente dal libero commercio o di persone ostili allo status quo per altri motivi. Che siano fondamentalmente del primo tipo può rivelarsi una conferma per chi crede che si può più facilmente capire il perché la gente che ha patito un danno economico sia adirata, rispetto al perché la gente che non ha di che lamentarsi sotto l’aspetto finanziario vorrebbe semplicemente mandare tutto all’aria.
Eppure, nella confusione politica, si può avvertire che ci troviamo davanti a qualcosa che non si vedeva in paesi come la Gran Bretagna e gli USA dal 1945: la gente che discute di ciò che Marx chiamava la vera natura delle relazioni sociali. Il terreno politico è in qualche modo terra bruciata. E, man mano che la politica continua a mostrare i suoi tradizionali limiti, dando un pessimo spettacolo, possiamo avvicinarci a capire la sostanza di tali relazioni.
Non è detto che esse siano solo economiche. Il tema principale del libro di Stedman Jones è che Marx e Engels, ossessionati dalle classi, ignorarono la forza di altre forme di identità. Una di esse è il nazionalismo. Per Marx e Engels, il movimento dei lavoratori era internazionale. Ma oggi pare di vedere, fra chi ha votato per la Brexit, per esempio, un ritorno al nazionalismo e, negli USA, un impeto di nativismo. Stedman Jones aggiunge che Marx e Engels non hanno saputo valutare il fatto che le agitazioni dei lavoratori del diciannovesimo secolo avevano per scopo, con l’ammissione al voto, l’inclusione politica, non la proprietà dei mezzi di produzione. Quando quello scopo venne conseguito, le tensioni calarono.
Ma il voto non è più una prova di inclusione. Quello che avviene nelle ricche democrazie potrebbe non tanto essere una guerra fra chi ha e chi non ha, cioè una guerra fra i socialmente avvantaggiati e i rimasti indietro. Nessuno, in condizioni di povertà, non scambierebbe la propria vita con una migliore, ma ciò che la maggior parte delle persone probabilmente vuole è la vita che ha. Oggi si ha più paura di perdere quella, piuttosto che desiderarne una diversa, anche se probabilmente molti sperano che i loro figli siano in grado di condurre una vita diversa se ne avranno la possibilità.
Fra le caratteristiche della società moderna che esacerbano la paura e minacciano la speranza, la distribuzione della ricchezza potrebbe non essere la più importante. Alla gente interessa il denaro, ma anche, e perfino di più, lo status, proprio perché lo status non si compra. Lo status è rapportato all’identità proprio come è rapportato al reddito. Purtroppo, è anche un gioco a somma zero. Le lotte per lo status sono socialmente divisive, e somigliano alla lotta di classe.
Ryan, nel suo libro su Marx, fa un’osservazione che lo stesso Marx avrebbe potuto fare. «La repubblica moderna», dice, «che cerca di porre l’uguaglianza politica al di sopra dell’ineguaglianza economica non è di alcun sollievo». È un problema relativamente recente, dato che l’ascesa del capitalismo moderno è coincisa con quella delle moderne democrazie, rendendo l’ineguaglianza del benessere slegata dall’eguaglianza politica. Ma la distribuzione iniqua delle risorse sociali non è nuova. Uno dei punti più chiari che Piketty descrive, è che «in tutte le società conosciute, in ogni tempo, almeno metà della popolazione non ha praticamente posseduto nulla», mentre il 10% più ricco possedeva «quasi tutto ciò che c’era da possedere».
Probabilmente ciò non è valido per le società tribali, e forse non lo è neanche per i primi Stati democratici, come la Atene di Pericle (perlomeno, non per i cittadini). Ma l’ineguaglianza è stata fra noi per moltissimo tempo. Ciò non è stato invertito dal capitalismo industriale del diciannovesimo secolo, e lo stesso può dirsi del capitalismo finanziario del ventunesimo secolo. Il solo fattore in grado di invertire la tendenza è un’azione politica mirata a cambiare sistemi che, a troppa gente, sembrano essere semplicemente lo stato di cose naturale. Abbiamo inventato i nostri sistemi sociali; possiamo alterarli quando essi operano contro di noi. Non ci sono dei che ci fulminano a morte se lo facciamo.
Pubblicato sul New Yorker il 10 ottobre 2016. Traduzione di Sergio Farris rivista da Thomas Fazi.
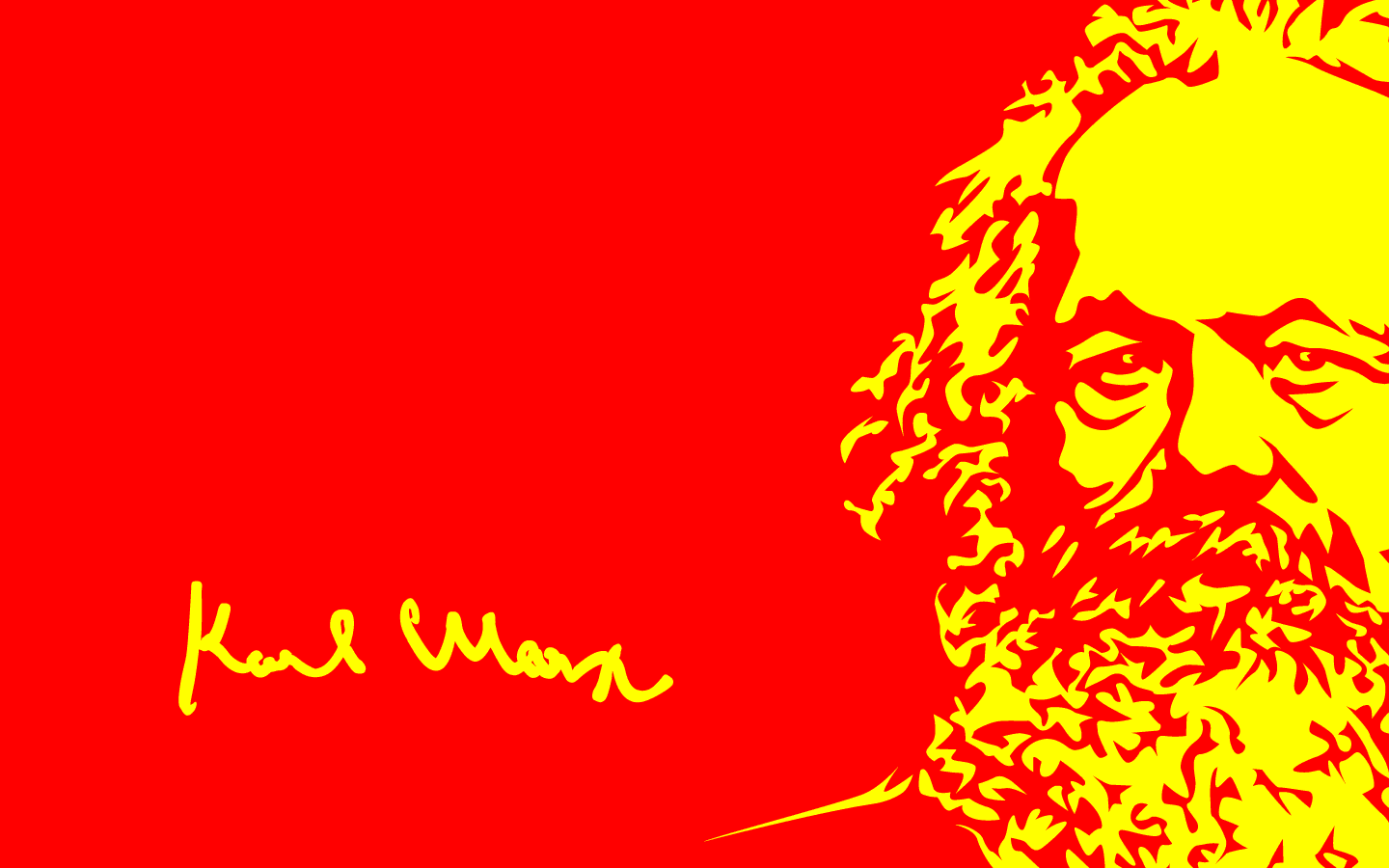




![[foto: Vladimir Yaitskiy/Wikimedia Commons]](https://www.eunews.it/wp-content/uploads/2025/05/Europe-Day-350x250.jpg)






